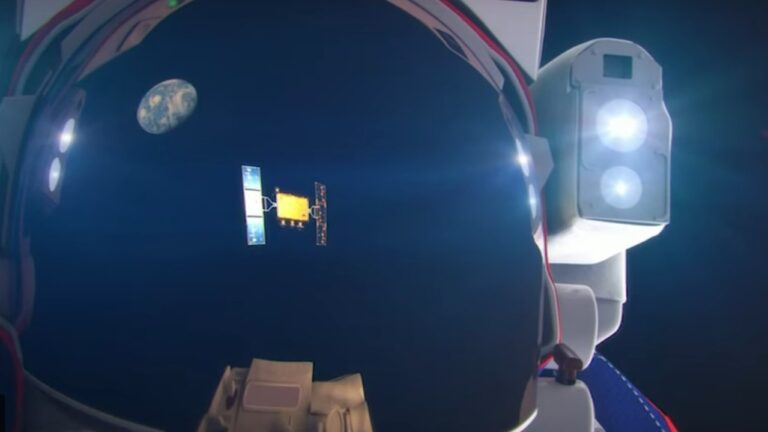Pubblica Amministrazione e Compliance
Scrivere di Compliance nella Pubblica Amministrazione (PA) potrebbe apparire secondo i punti di vista poco realistico, piuttosto ottimista, o semplicemente non facile (e personalmente opto per quest’ultima soluzione). Pur riconoscendo che il termine Compliance sia ormai abbastanza diffuso nel mondo degli studi e delle imprese, a beneficio di chi possa non essere edotto, e della materia e del contesto operativo, ne traccerò un breve excursus.
Sul web è facile trovare indicazioni a riguardo e una di esse, ad esempio, riporta che:
“la compliance cura e consolida l’immagine aziendale dal punto di vista della correttezza delle procedure e del rispetto delle norme, al fine di non incorrere in sanzioni che potrebbero danneggiare la reputazione dell’azienda nei confronti dei clienti, dei partner e di tutte le parti interessate in generale.”
Questa definizione chiarisce che il campo d’intervento della compliance è nel mondo delle imprese e dell’organizzazione aziendale, in un contesto di prodotti o di servizi offerti, acquistati o fruiti da utenti, clienti e pubblico interessato.
Per fissare ancor più il punto, sottolinerei che nel nostro ordinamento non è data una definizione esplicita di compliance. Nel nostro Paese, per indicare tale funzione, si parla di “conformità” (più in generale di conformità alle norme), e ritengo che il termine sia derivato da quella che s.e. è la sola definizione riportata in un testo normativo interno, il cui contesto riguarda la Direttiva Europea MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) e attiene alla legislazione inerente alla valorizzazione del risparmio e alla tutela dei risparmiatori. Tale direttiva – 2004/39/CE – imponeva alle imprese di riferimento l’obbligo d’istituzione di una funzione di compliance, chiarendo peraltro che nel mondo delle imprese soggette alla MiFID poteva anche non essere presente la funzione di audit, ma quella della compliance era obbligatoria. Nel recepimento nazionale di tali disposizioni, la Banca d’Italia definisce, nelle sue “Istruzioni di Vigilanza”, la tipologia di rischio che la “nuova” funzione deve presidiare:
“Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di leggi o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).”
Ne conseguì che la compliance, fino ad allora sconosciuta ai più, trovò finalmente dimora anche nel nostro Paese, dove facevano eccezione alcune realtà economico-industriali proiettate sui mercati esteri o di diretta emanazione estera, dove già tale funzione era ampiamente operativa e diffusa da decenni. A rischio di apparire irriverente, mi sento di dire che ciò avvenne in un certo senso obtorto collo, in quanto la funzione fu imposta da normative esterne (UE). È doveroso che spieghi il senso del mio “obtorto collo”: il sistema attinente le attività finanziare e l’impiego del risparmio, nel quale fu per primo introdotta normativamente quella che a tutti gli effetti era una “nuova” funzione, era già accompagnato nel suo operare da plurime strutture di vigilanza e controllo a diversi livelli, e l’introduzione della compliance fu nell’immediato vissuta dalle imprese del settore, obbligate ad ottemperare in tempi anche piuttosto stretti, come un ulteriore aggravio e costo da sopportare e considerato peraltro, secondo i punti di vista allora prevalentemente sussurrati, non del tutto necessario: si trattava di una nuova casella da riempire, da affidare a qualcuno con un’etichetta sulla porta, e devo dire che le soluzioni proposte e al momento adottate furono da questo punto di vista, in alcuni casi, anche piuttosto “creative”.
Fortunatamente, furono poi man mano chiariti aspetti, indicate regole e spirito di approccio, diversi e più costruttivi rispetto al poco favore iniziale, con uno sforzo tutto sommato—benché obbligato—piuttosto volenteroso nel trovare e perseguire la giusta dimensione, non solo operativa, ma motivazionale, una volta che questa venne meglio delineata e compresa.
Rispetto al termine “conformità” chiarisco subito che non lo condivido. Lo considero anzi inadeguato se non inadatto. Per essere più esplicito, lo vedo privo, dal punto di vista comunicativo, di afflato educativo. Conformità è un termine che richiama “l’essere conforme”, “conformarsi”, in una accezione che trovo abbia anche riflessi non positivi. Conformarsi vuol dire agire in modo conforme: conformarsi alla legge, alle regole, alle disposizioni vigenti, ma anche adattarsi con facilità, ovvero conformarsi alle opinioni, agli usi prevalenti, alle mode
È pur vero che il conformarsi può rappresentare una scelta, ma l’idea che è possibile avvertire nell’uso comune è che essa possa attenere più a una scelta individuale—certamente legittima—rispetto alle congiunture affrontate, necessità e convenienze vissute, ma non di sistema. In teoria, cioè, ci si può anche conformare, per convenienza o necessità, a comportamenti apparentemente corretti ma che nella sostanza possono non esserlo affatto in ragione dell’intenzione o di scopi ulteriori.
Quando osservo di trovare mancante la percezione del senso educativo nel termine conformità—del quale avverto al contrario un significato impositivo—è perché nelle società attuali, pensiero filosofico a parte, pare prevalente la sensazione che ogni cosa venga misurata in termini sì di valore, ma più spesso in senso economico-monetario piuttosto che ideale.
Quella appena espressa è una riflessione posta come spunto per sottolineare l’importanza, nell’ambito PA, di far propri quindi, non solo i valori, ma anche le procedure e i presidi di controllo che caratterizzano l’azione di una funzione di compliance. Procedure e presidi, da strutturare per la gestione delle attività, non solo al fine di tenerle meramente in linea con le disposizioni normative, ma anche per costruire un modello organizzativo che permetta un controllo nel continuo su atti e processi. Modello che deve essere condiviso da tutte le strutture e operatori coinvolti, al fine di renderli soggetti e non solo oggetti dei controlli stessi, e tale da portare a superare l’avversione ai controlli presente in qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia. Consapevolezza e condivisione, da parte dei singoli e non solo, della giustezza delle regole che governano il sistema, sono i mattoni imprescindibili della convivenza sociale e della corretta amministrazione degli interessi comuni.
Tornando quindi a cosa sia la compliance, e assunto che essa è inquadrata e strutturata come funzione e attività di controllo (come già accennato, l’ennesima), perché promuovere la sua necessità, o anche, perché soffermarsi su come diffonderla o incardinarla, dal privato, anche nella PA?
Pare corretto interrogarsi e riflettere su quanto questo abbia senso, in un Paese che nonostante gli sforzi impiegati e i progressi raggiunti soprattutto negli anni più recenti, nella semplificazione normativa, trasparenza e adeguamento tecnologico della PA, ancora soffre un deficit di efficienza stratificato, aggravato peraltro dal sentore di rischi, sempre dietro l’angolo, di irregolarità diffuse quando non di corruzione.
Di fronte a questi interrogativi, trovo che la risposta possa essere più che positiva, ove si consideri che l’azione della compliance—e questo vale tanto per le organizzazioni private che pubbliche—non si focalizza sui controlli preventivi, forieri spesso di aumentare la burocrazia e la lentezza della macchina amministrativa, ma neanche su quelli successivi, che portano cioè a determinare a posteriori conseguenze sanzionatorie senza tuttavia avere impedito comportamenti illegali o irregolari. La compliance deve al contrario agire in fase di avvio dei processi e successivamente monitorarli, al fine di generare un contesto che sia favorevole al rispetto delle regole e all’adozione delle migliori prassi operative (c.d. best practices).
In linea di principio l’azione della PA dovrebbe per definizione essere conforme alla legge e ai regolamenti. Per dirla in altri termini, poiché i soggetti pubblici esistono per perseguire un interesse pubblico, tutti essi dovrebbero essere per primi rispettosi delle regole, ovvero: compliant, alle normative di rango primario e secondario.
I dati ISTAT sulla situazione del Paese e dell’economia italiana hanno man mano negli anni dato lo specchio delle criticità e cambiamenti, attuati, e ancora necessari. Da ultimo anche i dati del 2024 non hanno mancato di segnalare, nelle difficoltà incontrate rispetto alle situazioni indotte da elementi esterni al nostro Paese, la resilienza e la reattività, e dei singoli e del sistema, ai cambiamenti e alle difficoltà pur provenienti da situazioni anche globali, con interventi volti al mantenimento e difesa, per quanto e ove possibili, degli interessi del nostro tessuto civico ed economico, ma anche in prospettiva futura di miglioramento e modernizzazione del contesto sociale e produttivo.
La velocizzazione continua delle attività, mercati e concorrenza, si è scontrata spesso con l’inefficienza della macchina amministrativo-burocratica. Quante volte imprenditori grandi e piccoli hanno esternato le preoccupazioni del sistema economico-produttivo riguardo l’arretratezza, lentezza, e scarsa capacità del nostro sistema amministrativo nello stare al passo con i sistemi di altri Paesi, con la penalizzazione che ne consegue per le nostre imprese in termini di velocità concorrenziale, rispetto ad altri che optano per procedure più snelle.
Tuttavia, spesso l’argomento, pur legittimamente sentito e senz’altro reale per plurimi aspetti, si è qualche volta complicato nel soffermarsi sul fatto che a meno controlli corrisponda o possa corrispondere, una maggiore criticità per corruzione.
Di fatto, la situazione attuale è che la compliance viene comunemente evocata all’interno del mondo societario privato, e oggi come in passato, raramente accostata alla PA, nonostante che nel settore pubblico sia manifesta l’esigenza di effettuare verifiche rispetto all’osservanza della normativa specifica, quale forma di garanzia dell’attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità che devono informarne l’attività.
È l’articolo 97 della Costituzione, a indicare che:
“I pubblici uffici sono organizzati […] in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
E in effetti il processo di ammodernamento della macchina amministrativa si è da allora orientato verso una visione di mutamento culturale della PA, che nella seconda metà del secolo scorso non poteva che riferirsi a una sorta di visione aziendalista degli apparati e strutture dello Stato, portando a esplorare in tale contesto, gravemente elefantiaco e per tanti versi opaco, logiche di gestione prima solo privatistiche, ovvero ipotesi di pianificazione, controllo ed efficienza delle strutture e misura dei risultati, nonché, non certo ultime, di accettazione e attuazione della trasparenza degli atti e operativa.
Nel 1979 il Ministro per la Funzione Pubblica, Massimo Severo Giannini, commentava nel suo “Rapporto sui principali problemi dell’Amministrazione dello Stato”: “[…] il diverso tipo di rapporto tra amministrazione e cittadini trova scarsa emersione nelle leggi, alcune delle quali ormai troppo invecchiate, e comunque non rispettose della garanzia della libertà dei cittadini, tra cui prima la libertà di essere informati circa i fatti dei poteri pubblici […]” e ancora, a proposito del rapporto di fiducia e della figura dello Stato: “[…] per i cittadini esso non è un amico sicuro e autorevole, ma una creatura ambigua, irragionevole, lontana […]”.
Nel 1993 il Dipartimento per la Funzione pubblica, Ministro dell’epoca Sabino Cassese, presentò il suo “Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni”. Anche in questo caso numerose furono le indicazioni riguardo gli impedimenti e le necessità gravanti sulla PA. Ottima fu la focalizzazione, operata con la stesura di un vero e proprio decalogo, che indicava in modo diretto e concreto gli aspetti problematici che necessariamente si posero e si pongono tuttora, a monte di qualsivoglia attività di analisi e studio rivolta all’applicazione di un’attività di compliance nella PA.
Per quanto interessante, sarebbe qui troppo lungo riportare il documento per intero. Lasciando alle note a fine testo i dovuti riferimenti, ne trascrivo alcune parti al fine di fornire un contributo rispetto a quanto appena affermato in tema di compliance nella PA:
1 – “gli uffici pubblici debbono rispondere alla domanda di servizi collettivi, dall’ordine all’istruzione, alla tutela della salute, alla salvaguardia dell’ambiente. Anche per i servizi collettivi il consumatore è sovrano. Se le funzioni pubbliche non rispondono a queste esigenze, perché la loro organizzazione è imperfetta, o perché gli interessi dei fornitori dei servizi prevalgono su quelli dei fruitori, gli uffici pubblici finiscono per costare più di quanto rendono”.
5 – “se gli uffici pubblici non riescono a misurare il ruolo e rendimento, il rispetto della legge diventa un rito formalistico, che perde di vista il fine ultimo della loro attività”.
10 – “se la voce dei fruitori dei servizi (che sono anche i contribuenti e sopportano, quindi, il loro carico fiscale) non si fa sentire, prevarranno gli interessi dei fornitori o di quelli dei clienti”.
Quanto appena riportato, per concordare nuovamente sul fatto che la trasparenza non può che aiutare la Pubblica Amministrazione a essere compliant. Trasparenza infatti vuol dire migliore gestione della cosa pubblica dal punto di vista sia economico che organizzativo, oltre che stimolo alla capacità dell’amministrazione, ad essere trasparente e ascoltare i cittadini, e alla responsabilizzazione delle funzioni manageriali pubbliche (c.d. accountability).
A sottolinearne la rilevanza, è peraltro anche riconducibile allo stesso articolo 97 della Costituzione, il principio di pubblicità dell’azione amministrativa, che impone alla PA l’obbligo di rendere visibile e verificabile il proprio operato, sia per quanto svolto all’interno della struttura pubblica, sia e soprattutto all’esterno di essa, al fine di rendere possibile l’esercizio del potere di controllo da parte dei cittadini.
Come anticipato in apertura, l’argomento compliance nella PA non è semplice, è vasto, e capace di portare nei ragionamenti, a considerare e riflettere su molteplici aspetti e fronti aperti, tutti indubbiamente esplorabili ma con necessità di tempi e spazi adeguati.
Cercando di arrivare a concludere, la compliance nella PA non può che richiamare alla mente il principio di legalità che ne deve modellare l’organizzazione e l’attività: quel “buon andamento” il cui principio, incardinato all’articolo 97 della Costituzione, trova attuazione con la legge n. 241/1990 sul procedimento e la trasparenza, emanata al fine di assicurare, appunto, l’efficacia dell’azione amministrativa e la sua rispondenza all’interesse pubblico, ovvero la sua efficienza, efficacia ed economicità.
E qui vale la pena notare che i principi di economicità ed efficacia costituiscono in effetti criteri di matrice economico-aziendalista normalmente seguiti per le attività private.
Questo ulteriore riferimento a concetti in uso nel campo “privato”, porta a considerare per esso, in tema di responsabilità e corruzione, il Dlgs. 231/2001, che stabilisce le responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi commessi da dipendenti o amministratori, mentre, dal lato pubblico, la legge n. 190/2012 (c.d. legge Severino), che introduce nella lotta alla corruzione un approccio integrato di tipo preventivo-repressivo con misure volte appunto a prevenire e reprimere la corruzione nella pubblica amministrazione, l’introduzione nel codice penale di modifiche alla disciplina dei reati contro la PA, e l’istituzione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), deputata alla prevenzione della corruzione nell’ambito della Pubblica Amministrazione e nelle società da essa partecipate e controllate.
Quale estensione logico-formale di questa dualità, si può dire che il punto di contatto fra il modello pubblicistico (L. 190/2012 e ANAC) e quello privatistico (Dlgs. 231/2001), è rappresentato dalle società private controllate da enti pubblici.
Ancora, il più velocemente e brevemente possibile, la L. 190/2012 istituisce nella PA la figura del RPCT, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (le due figure, inizialmente separate, confluirono poi in una unica con il Dlgs. n. 97/2016).
Proseguendo nel riepilogare la normazione continua, tesa negli intenti a innovare, modificare, rendere più efficace l’azione amministrativa delle strutture pubbliche, vale anche rammentare che L’ANAC approva su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che viene aggiornato periodicamente tenendo conto delle novità normative. Tale piano nazionale fornisce alle amministrazioni le linee di indirizzo utili alla redazione del Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), al fine di promuovere efficaci misure, appunto, di prevenzione della corruzione. In proposito non è inopportuno segnalare che i primi esami compiuti dall’ANAC rispetto a tali piani triennali, risultarono essere intesi dalle amministrazioni soggette al controllo come un mero adempimento formale senza importanza: un altro dei documenti da stilare e mettere agli atti per dimostrare di avere adempiuto. L’ANAC poté verificare infatti che addirittura si trattava in diversi casi di copia e incolla da documenti di altre amministrazioni similari, fatto senza neanche cambiarne i riferimenti. Si ignorava cioè completamente il fondamento dei piani da produrre e mettere in atto, e ancor più la loro dinamicità, del tutto opposta alla staticità di un adempimento appena formale.
In tale mutevole scenario teso alla semplificazione, trasparenza e ammodernamento della macchina amministrativa, soggetto cioè a più implementazioni, occorre anche rammentare il PIAO, acronimo di Piano integrato di attività e organizzazione. Introdotto dal decreto legge n. 80/2021 articolo 6, e poi definito dal decreto ministeriale del 30 giugno 2022, fu ideato, come strumento di semplificazione per le pubbliche amministrazioni, come documento unico di programmazione e governance teso a superare la frammentazione degli strumenti in uso, accorpando tra gli altri i piani della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere, del lavoro agile e dell’anticorruzione, con durata triennale, ma aggiornato annualmente.
Per rimarcare quanto incida e quanto sia forte nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività della Pubblica Amministrazione il sentimento di contrasto al pericolo (non più solo rischio) di corruzione, e quanto ciò necessariamente contribuisca ad appesantire la macchina amministrativa, si potrebbe proseguire citando le normative, introdotte anche nella PA, riguardo il “whistleblowing”. Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore, che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze, che ragionevolmente possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. In parole povere, si tratta di segnalare alla propria organizzazione tali situazioni, con tutti i rischi che ne possono conseguire per il segnalante. Da qui le norme di tutela e di protezione dell’anonimato dettate dal Dlgs. 24/2023. Antecedentemente ad esso, nel settore pubblico la regolamentazione del whistleblowing era garantita dall’art. 54-bis del Dlgs. 165/2001, che disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il dipendente pubblico, nel caso di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all’ANAC o all’Autorità giudiziaria, di condotte illecite da lui apprese.
Ecco, è anche quest’ultima fattispecie, ovvero l’introduzione del principio che ci si debba avvalere anche del sospetto e della delazione, in aggiunta al già presente affastellamento di procedure, adempimenti e controlli burocratici, a dover rattristare e spingere a trovare una soluzione a quella che deve essere riconosciuta e indicata come carenza di cultura, non tanto del valore dei controlli in sé, quanto di cultura di appartenenza alla comunità sociale, al rispetto delle norme che si comprendono come giuste in quanto non solo accettate perché imposte, e cui è obbligatorio conformarsi, ma perché condivise nei principi in quanto attinenti ai comportamenti convinti delle persone-cittadini.
Va riconosciuto che ad oggi di strada ne sia stata fatta parecchia, e da ultimo il PNRR, soprattutto negli anni più recenti, ha dato un forte contributo e ulteriore impulso all’opera di ammodernamento, semplificazione e trasparenza nella PA. In tutte queste norme, autorità, strutture e adempimenti, occorre continuare a indicare, e infine trovare, benché affatto semplice, la via per introdurre un vero spirito di compliance anche nella Pubblica Amministrazione, allo scopo di promuovere e diffondere nei controlli una cultura di legalità che sia funzionale al monitoraggio dei processi, dalla fase di avvio al loro continuo svolgersi, per attuare una cultura di compliance che sia quella dell’esatta applicazione della norma. L’esatta applicazione che intendo è certamente coerente e conseguente alla lettera del testo normativo, ma trae fondamento, nella sua interpretazione, dalla ragione di chi applica e controlla con l’attenzione alle motivazioni che hanno determinato la disposizione, intendendola non come strumentale, bensì utile. E per esatta va quindi intesa la norma “che rispettiamo perché la comprendiamo come parte dell’equilibrio fra diritti, doveri, aspettative, aspirazioni, del nostro sia pur perfettibile contesto sociale”: strumento di controllo, quanto di progresso.
Per chi volesse esplorare altri punti di vista, segnalo i seguenti link:
nonché, per qualche ulteriore approfondimento:
https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/05/Rapporto-Annuale-2024.pdf
e:
AICOM (in collaborazione con Dexia Crediop), La compliance nella pubblica amministrazione. Semplificazione, trasparenza e controlli. Bancaria Editrice, 2013.
AICOM e Compliance Lab, Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato. Edizioni Kappa, 2018.
COMPLIANCE, di AAVV a cura di Alessandro Orlandi, Raffaele Torino e Enzo Maria Tripodi, Giuffrè, 2022, in particolare: Parte III La Trasparenza, Sezione I, Trasparenza, Informazione e Partecipazione; Parte IV L’anticorruzione, Sezione I, L’ambito Pubblico.
COMPLIANCE, Il Futuro è Oggi, di Gennaro Giancarlo Troiso, PM edizioni, 2020.